Cento Sonetti
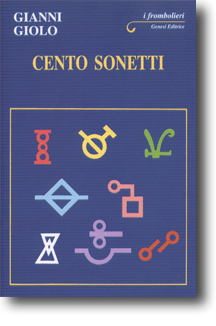

Premio I Murazzi per l'inedito 2011 (dignità di stampa)
Motivazione di Giuria:
L'omaggio reso al sonetto diviene molto di più di un cimento letterario sorretto da una perfetta educazione umanistica e da uno sviluppato talento di orchestrazione delle possibilità del dire in forme chiuse. In verità, Gianni Giolo insegue quasi per ironia la misura dell'ordine armonico nel grande caos della storia letteraria dell'Occidente, che gli è tutta presente e chiara dall'antichità aurea latina fino alla contemporaneità del minimalismo biografico e quotidiano attuale, al punto di condensarlo nella mirabile quartina: "io non so perchè sono giunto / a tanta affannosa confusione, / ad un segno così defunto / di vita e di disperazione".
La Giuria all'unanimità attribuisce la dignità di stampa.

Che senso ha scrivere sonetti oggi? Breve e amplissimo carme lo definiva il Carducci, il sonetto è la forma metrica che meglio permette agnizioni avanti e indietro nel tempo, in una vicenda secolare che ancora, quasi miracolosamente, sembra permettere il circuito sanguigno, insomma la comunicazione tra epoche e individui lontanissimi, la continuità, la vischiosa compenetrazione di un corso storico non definitivamente interrotto e lacerato. Non si tratta solo di accertare che di sonetti se ne sono scritti dalla prima metà del Duecento ad oggi, ma di accorgersi che nel corpo di questa forma rigorosa e malleabile, infinitamente variabile e suscitabile a piacimento dall’imprinting stilistico, espressivo e artigianale dell’autore, si possono registrare linee di sutura, scarti, innovazioni, tentativi di riequilibrio: continuità e frattura, appunto, tenuta e lacerazione, fuoriuscita e pertinenza a una storia
Dopo il miracolo della poesia del Tasso, che divelle le fondamenta retoriche del petrarchismo per innestarvi un nuovo sentimento notturno, anticipando la tramatura e l’aria del Foscolo e del Leopardi, in cui il mondo di invocazione e fola è già in nuce nelle stelle tremanti, immaginate come pietose agli umani affanni, il sonetto raggiunge una maestosità e capacità di espansione ritmica e sintattica, un’intrinseca drammaticità, duttilità e vibrazione patetica che non hanno uguali.
Nell’Ottocento esso trova una fase di aureo splendore e maturità, di fervida pienezza e fruttuosità con la sceltissima serie del Foscolo che allinea dodici magistrali esemplari e soprattutto tre individui di tale complessità (metrico-sintattica e strutturale) da rappresentare un episodio capitale nella storia della forma metrica (sono, naturalmente, i sonetti alla sera, a Zacinto e in morte del fratello Giovanni). I miei prendono le mosse da tale forma poetica sostituendo ai miti foscoliani dell’esilio, della tomba illacrimata, della gloria e dell’aurea beltà, unico ristoro al vaneggiar delle menti mortali, i temi della solitudine, della delusione e della morte. Non mancano influssi dei sonetti di Zanella che, nel lento fluire degli endecasillabi e nel cristallo di un linguaggio chiaro e puro, ci restituisce la pienezza di senso e di suoni della campagna vicentina. Mentre il Pascoli fu un frequentatore piuttosto parco del sonetto, limitandosi ad usarlo nelle Myricae, il D’Annunzio invece svariò con ogni sua risorsa e abilità per la piccola cattedrale dei quattordici versi, in lungo e in largo, insistendo su un mortale esaurimento sensuale e ritentando una nota musicale, altisonante ed eletta quando non apertamente anticata. Con Montale la forma, sentita come tendenzialmente compromessa e lisa, viene evocata con rime eccedenti, nascoste o irregolari, come a smorzare il senso di ripetizione formulare dello schema. Caproni invece si immerge nella forma per restituirla non più compromessa con l’inerzia e la desuetudine, reinventandola nei suoi stessi fondamenti ritmici e sintattici.
Oggi il sonetto conosce una nuova stagione dopo che si è fatta strada l’idea che la liberazione metrica novecentesca stia esaurendo la sua spinta o, almeno, che il versoliberismo non abbia più il dominio incondizionato del poetico (Piccini). Dopo gli anni Ottanta del Novecento si registra un incremento significativo nella produzione della forma, perché acquista sempre più coscienza che si pone come antidoto al linguaggio effimero, ripetitivo e povero dei mass media. Oggi la rima come scrive Magris è intesa non già come espressione di sentimentalità tradizionale bensì quale forma perfetta per evocare il Nulla, espressione di quel nichilismo che, da Nietzsche in poi, sembra il destino dell’Occidente e segna il trionfo della forma perfetta, di una perfezione però che, come la luce d’estate, fa sentire il nulla dell’esistenza umana, il suo nostalgico e spietato finire.
La rima diventa così una straordinaria evocatrice dell’inconscio e, come dice la Valduga, la prigione della forma è la più alta espressione di libertà, perché essere costretti a scegliere tra poche parole ci fa dire di noi qualcosa che non sapevamo neppure di sapere. La rima conferisce al testo una circolarità e una chiusura che ne assolutizza la durata e lo sottrae al fluire labile ed effimero del tempo.
Scarica il documento completo in PDF: 
|